In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Tuesday, October 24, 2017
Friday, October 23, 2020
Dall'Arte allo Zero
E' uscito in libreria il libro Dall'Arte... allo Zero. Piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria di Vittorio Marchis (Mondadori 2020).
In una società sempre più condizionata dalle scelte tecnologiche, gli operatori nei settori più avanzati della tecnoscienza, così come i tecnici che operano nell’industria, si trovano ad affrontare prospettive filosofiche che risultano centrali e sotto molti aspetti dirimenti. Senza guardare ai ‘massimi sistemi’ e con la volontà di offrire una serie di spunti alla riflessione, i capitoli di questo libro affrontano contesti e problemi tipici della società contemporanea. Si passano in rassegna i temi che coinvolgono l’ingegneria sul fronte della filosofia, indagando le sue frontiere, contaminate dalla tecnica. I titoli di ciascun capitolo, articolati a coppie di concetti, ne evidenziano gli scarti, piuttosto che le posizioni opposte. Il libro si presenta come una prima porta verso una cultura non più vincolata dalle chiusure disciplinari, ma che riconosce nel melting pot dei saperi ‘politecnici’ la nuova sfida culturale del terzo millennio.
Indice degli argomenti:
1. All’inizio; 2. Arte / Tecnica; 3. Beni / Cose; 4. Caso / Causa; 5. Disegno / Immagine; 6. Efficacia / Rendimento; 7. Fantasia / Invenzione; 8. Gioco / Competizione; 9. Habitat / Ecosistema; 10. Intelligenza / Ragione; 11. Linguaggio / Segni; 12. Macchina / Corpo; 13. Naturale / Artificiale; 14. Ordine / Disordine; 15. Piacere / Dolore; 16. Qualità / Quantità; 17. Resilienza / Fragilità; 18. Sistema / Finalità; 19. Tempo / Spazio; 20. Utensile / Lavoro; 21. Vita / Morte; 22. Zero / Uno / Infinito; Sullo scaffale; Indice dei nomi.
Thursday, December 3, 2020
Leonardo SInisgalli a Milano
"Civiltà delle Macchine", n. 5, 1955
Le mie stagioni milanesi, di Leonardo Sinisgalli
REDUCE da Padova dove ero andato per le prove scritte di Scienza delle
Costruzioni e di Impianti elettrici (il mio primo passaggio sul Po) capitai a
Milano la prima volta e mi feci portare in viale Romagna dove da qualche anno
abitava mia zia. Era il novembre del 1933, se ricordo bene. Avevo addosso un
impermeabile, retaggio degli ultimi anni di università. M'era servito anche da
ufficiale: bastava che appuntassi sul bavero due stellette minute. E il bavero,
infatti, era tutto punzecchiato come i polpastrelli di Madame Bovary. Ricordo,
ma non c'entra niente con questa storia, la sera in cui una ragazza che
frequentava la mia pensione in piazza Indipendenza, vicino alla nostra caserma,
volle mettersi il mio impermeabile, il mio berretto, la mia sciabola, gli
stivati, gli speroni, e uscire sulla strada per farsi salutare dai nostri
artiglieri in libera uscita. A Padova e a Milano quel triste indumento si
rivelò non soltanto precario, ma veramente povero. E la mia padrona di casa a
Lambrate dovette simpatizzare con il cupo ingegnere mussulmano che veniva ad
affrontare la nebbia così disarmato. Chi ha letto qualche mio libro conosce
queste cose in un'altra chiave. Qui debbo toccare ragioni e non immagini, qui
devo parlare della mia educazione al lavoro più che delle mie effimere
conquiste di stile.
Prima di arrivare al noviziato, prima di giostrare con gli orari e i doveri,
io ebbi un lungo periodo di disoccupazione. Ma il mio temperamento riuscì a
salvarmi anche dai compromessi che, per stanchezza e per inedia, avrei potuto
forse accettare quando ero davvero stufo di non far niente. "A me pare che
ti non fai na got " mi disse la vecchietta di piazza Tricolore quando si
accorse che mi svegliavo tardi, uscivo per mangiare, tornavo nella camera il
pomeriggio per dormire. Ho raccontato tante volte agli amici che quella
vecchietta spostava perfino le sfere dell'orologio per pigliarmi in castagna e
proibirmi di metter piede nella stanza prima delle ore pomeridiane, l'ora in
cui la mia camera al quarto piano, sul viale Biancamaria, poteva dirsi
rassettata. Carmine Stella, il fratello di mia zia, mi aveva promesso un posto
presso
Rasentavo le fabbriche verso il mezzogiorno, quando mi ero appena alzato dal
letto, sentivo il fischio delle sirene come una frustata, guardavo le file
degli operai che inforcavano le biciclette, e quelli che andavano all'osteria,
e i muratori che consumavano sui margini del prato i loro cartocci. Avevo pietà
di me. Ma non ero infelice, i miei compagni erano l'Amore e
Anche la mia speranza di trasferirmi a Biella in una fabbrica di tessuti
svanì molto presto. Intanto io arrotavo i denti attorno agli ossi di manzo che
mi affannavo a spolpare in una mensa a prezzo fisso, in piazzale Oberdan,
vicino all'Ufficio delle corse. Anche l'ingegnere Picker mi aveva promesso di
farmi lavorare nella sua azienda. Mi rimisi a studiare elettromeccanica. Credo
che egli fabbricasse contatori e progettasse installazioni elettriche per le
case e le officine. Aveva lo studio in via Tadini, all'ombra di quegli alberi
indimenticabili che confinano con i giardini della bellissima ripa malfamata.
Risposi anche a una offerta di lavoro che la mia padrona di casa aveva letto
sul giornale. Ebbi la fortuna di essere chiamato, e una mattina di pioggia
raggiunsi via Borghetto cinque minuti prima delle otto. Mi diedero da leggere
un mucchio di stampati sulle applicazioni di una lega antifrizione. Poi mi
capitò di dover rispondere a una telefonata dalla Germania. Non potevo cavarmela.
Mi dissero che il lavoro richiedeva una perfetta conoscenza della lingua. Tirai
avanti fino alle cinque del pomeriggio. Me ne tornai a casa risollevato, dopo
quella tragica esperienza. La signora Mileo era afflitta della mia sorte. Ma
ero innamorato, avevo la mia bella tigre che divorava da Motta babà con la
crema. E poteva accadere intorno a me il finimondo, non me ne sarei accorto.
Riprendemmo quelle sere a giocare a scopa e a interrogare il mio incerto
destino.
L'estate venne da Bogotà un cognato di mia zia, Vincenzo Buraglia, con due
bei bambini che parlavano lo spagnolo degli angeli e mi chiamavano " il
capitano ". Vincenzo Buraglia era un meccanico provetto, pieno di genio e
di bontà. Mi trattava perfino con rispetto, per via della mia laurea. Ma si
accorse subito che io non sarei stato capace di avvitare un bullone o di
mettere a posto la punta di un trapano. Sapevo tanto di matematiche, ma capivo
pochissimo di macchine. Le mie mani erano rimaste stupide. Ero ammiratissimo
della sagacia di Vincenzo, gli invidiavo le nocche robuste e capaci, le
orecchie attente a qualunque irregolarità nel funzionamento dei cilindri.
Vincenzo distingueva i buoni vini e i cattivi lubrificanti. A Milano aveva
portato un suo brevetto, un nuovo tipo di carburatore a farfalla che avrebbe
dovuto costruire per
Era trascorso più di un anno. Un giorno il poeta Alfonso Gatto mi indicò un
avviso su una colonna del " Corriere ". " Può darsi che
t'interessi ", mi disse. Lo lessi: cercavano un ingegnere-giornalista per il
Servizio Propaganda di una Società. Andai in via Macedonio Melloni a presentare
le mie carte. Dopo qualche mese mi richiamarono e mi dissero di organizzare
lezioni e conferenze sull'arredamento e l'architettura moderna. Mi riempii la
borsa di campioni di linoleum. Intanto ero stato negli stabilimenti a Narni, in
Umbria, per seguire la fabbricazione dei rotoli. Ebbi l'occasione di viaggiare
di provincia in provincia. Passai ore bellissime a Pavia, a Mantova, a Cremona,
ore che non dimenticherò mai. Stavo fuori per cinque o sei giorni, qualche
volta per due settimane. Tornavo nella mia stanzetta di via Rugabella la sera
di sabato. Presi gusto al lavoro. Il lavoro mi restituiva il piacere di
starmene qualche volta a scrivere e a sognare, il piacere di vivere che avevo
quasi perduto. Scossi la mia accidia, mi svegliai. Arrivavo ai treni con solo
qualche minuto d'anticipo. Io ho quasi perduto la memoria ma queste minuzie che
ho racimolato di colpo devono aver avuto allora riflessi assai dolenti. Non ho
fatto sforzi per allineare i ricordi della mia preistoria milanese.
Un pomeriggio di estate del
Noi affermammo che una pagina stampata, una vetrina, un fotomontaggio
costituivano delle testimonianze nientaffatto trascurabili della nostra
civiltà, della nostra cultura. La fabbrica di Ivrea lavorava con una tolleranza
che non doveva superare il millesimo di millimetro; come potevamo noialtri
dimostrarci sciatti o approssimativi? Credo di aver io stesso facilitato allora
i primi incontri tra l'ingegnere Adriano Olivetti e Marcello Nizzoli, nello
studio di via Rossini, dove Nizzoli lavorava da almeno vent'anni. E fin da
allora ebbi modo di discutere con loro i primi simulacri in gesso e in legno di
quella che dopo qualche anno divenne la "Lexikon", la macchina per
scrivere più bella del mondo. Da uno stanzone che occupavamo sul cortile ci
trasferimmo al primo piano su via Clerici, e ricordo ogni sera il passaggio in
bicicletta, sempre alla stessa ora, dell'uomo-cane, il latrato che era per noi
come il suono dell'Angelus. Quel nostro mestiere non dispiaceva neppure ai
nostri amici. In via Clerici capitarono Vincenzo Cardarelli ed Elio Vittorini,
Quasimodo e Gatto, Sandro Penna e Vittorio Sereni. Capitarono pittori,
scultori, architetti. Persico era morto qualche anno prima e noi ci
consideravamo tutti suoi discepoli, perché fu lui, fu il suo esempio, i suoi
discorsi, i suoi incoraggiamenti a farci considerare allo stesso livello la
dignità del lavoro e la responsabilità dell'arte. Ci sentivamo sempre
confortati e ammoniti dalla sua cara ombra.
Le nostre audacie, i nostri entusiasmi, il mio fanatismo di allora non si
giustificherebbero, non si capirebbero se non ci fosse sullo sfondo una città
come Milano, il credito che i milanesi sanno dare alle operazioni che un poco
li sollevano dalla vita e dal senso comune. Io stesso non avrei mai preso sul
serio certi problemi se mi fossi immiserito su un piccolo Olimpo, se anch'io,
sull'esempio dei miei amici letterati, mi fossi impietrito nel mezzobusto con
l'illusione di entrare così di soppiatto nella storia. Milano ci diede il
coraggio di alimentare continuamente la nostra disposizione a comunicare col
prossimo, anche a costo di cambiare il physique du rôle, col vantaggio di
passare, come Seurat, per un personaggio qualunque, un borghese, più che per un
intellettuale stravagante, cinico, scettico e, tutto sommato, noioso.
Quel mio lavoro durò ininterrotto fino al principio della guerra. Nel nostro
atelier ci fu una fioritura incessante di immagini, di schemi, di apparati.
Come ho detto altrove, il dèmone dell'analogia ci suggeriva ogni giorno uno
spunto. I miei ragazzi erano di un'abilità portentosa, realizzavano in un
batter d'occhio qualunque fantasia, gli accostamenti più inattesi di oggetti,
di forme, di colore, di caratteri. Le vetrine che allestimmo nel negozio in
Galleria, per un paio d'anni ogni quindici giorni, erano seguite dal pubblico
come una vicenda cittadina, una gara, un exploit. Corrado Alvaro scrisse allora
una corrispondenza per "
La mia seconda stagione milanese porta il peso e la responsabilità dei
quarant'anni (i capelli grigi e l'emicrania, piazza Duse e via Zuretti, le
trattorie di Giuntoli e di Pepori), i colori giallo e rosso della Pirelli.
Dentro questi anni bisogna far entrare il trambusto di piazzale Loreto e gli
odori della Bicocca. Bisogna far entrare le Alpi che qualche volta, nei giorni
limpidi, io riuscivo a scoprire dalla finestra dell'ottavo piano del Palazzone.
Poi la monotona e bellissima storia del marciapiede di via Vittor Pisani, dalla
porta dell'Albergo Doria fino in fondo, dove, dall'altezza di un gradino appena
(il gradino di un marciapiede) si scende nel piazzale della Stazione. Si scende
sul piazzale con un salto di appena diciotto centimetri, che è stato sempre per
me, nuotatore impossibile, un vero e proprio t tuffo a testa in giù, dal
trampolino (del letto, dei libri, della solitudine) fin sotto il livello della
giornata di lavoro. La storia del marciapiede di via Vittor Pisani, questo
incredibile tappeto d'asfalto, più prestigioso di un tappeto orientale, più
ricco di un sottobosco, più enigmatico del fondo del mare, la racconterò
un'altra volta. So che una sera ho rivelato a Riccardo Manzi la mia scoperta e
siamo stati insieme due ore, a testa bassa, a ripercorrere su e giù, a leggere
rallentati duecento metri di film. È un film da fare, un film di duecento metri
(una misura assurda!) che forse nessuno intenderà: un film sulle crepe, sulle
incrinature, sui solchi, sulle lacerazioni, sulle cicatrici, sui cunicoli, sui
simboli, infine, che pioggia e nebbia e gelo hanno tracciato nel bitume. E poi,
eppoi c'è il trolley del tram numero 7.
Se sfoglio i miei appunti di allora, autunno-inverno 1948, trovo curiose
indicazioni, trovo i segni delle prime punture, il grafico della linea di
penetrazione del mondo della gomma nel inondo dei miei pensieri. Trovo scritto,
per esempio, che le vie del sonno sono serpentine, e c'è vicino a questa nota
uno scarabocchio che potrebbe essere anche un ritratto della tortiglia, del
cord, oppure l'ideogramma di un battistrada. Appresso trovo divertimenti di
questo genere: " I surrealisti devono aver cercato parole elastiche; Moore
ha scoperto una scultura pneumatica; Dalì ha fabbricato orologi di caucciù ".
E in altra pagina, trascritta l'ultima terzina di un famoso sonetto di Rimbaud:
" Où, rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme des lyres, je tirais les élastiques Des mes
souliers blessés, un pied contre mon coeur! ".
È chiaro, si tratta di schermaglie, di difese superflue, di raggiri
premonitori: il regno del flessibile sceglieva le vie più tortuose per farsi
strada nel mio cervello.
Poi ci furono le impressioni in fabbrica. " I fili, i canapi, le
trecce, i cavi dentro cui trascorreranno i fremiti delle acque, i sobbalzi
delle piogge e delle nevi. I fili di rame che svuotano i laghi, ecc. ". Il
29 novembre 1948 feci la seconda visita ai cavi (i cavi m'intrigavano non c'è
dubbio). " L'operazione più intrinseca che si compie entro queste immense
navate, questi altissimi padiglioni, consiste nel proteggere il rame dal
contatto diretto con la terra. È strano come tutti i traslochi delle cose più
delicate e lubriche, sangue, semenza, clorofilla, linfa, energia, vis, suono,
si compiano meglio all'oscuro, sottoterra. L'isolamento dei cavi deve evitare
le dispersioni di corrente, deve tamponare qualunque eventuale e possibile
emorragia. E gli operai addetti alle macchine fasciatrici hanno anche nella
figura qualcosa che ricorda gl'infermieri e gli aiuti delle sale operatorie.
C'è ancora di più: il sistema di bendaggio (gomma, carta, miscela, olio)
ricorda molto da vicino i processi di mummificazione. Con la differenza che
davvero entro questa basilica si opera una difesa dell'anima., perché
l'elettricità è tutta anima e niente corpo. Il midollo di questi possenti
pitoni (lunghi anche mille metri e grossi fino a centocinquanta millimetri) è
quasi sempre triplice, ternario, perché in effetti, l'energia è trigemina. È un
triangolo. Una trinità ".
Vedete, ero già posseduto. Ero perduto.
Fu in quella stessa epoca che visitai alla Bicocca il prof. Allavena e
conobbi il dott. Oberto, e mi documentai sulle macromolecole, sulla memoria
della gomma (l'isteresi elastica è memoria!) e sull'influenza che il nerofumo
(in polvere millesimale) e lo zolfo (il fiato di Satana) esercitano
sull'assetto delle catene molecolari.
Così dopo un rapido noviziato, tra alchimia e tecnologia, presi il mio posto
tra produzione e distribuzione, tra operai e clienti. Ebbi poco tempo per
sottilizzare sulla vendita e sul vantaggio. Mi buttai nella mischia, mi
attaccai ai telefoni. Ogni gesto doveva da allora diventare pubblico,
manifestarsi, chiamare, soccorrere, spingere, urtare, sedurre. Fu allora,
novembre 1948, che intorno a noi, Luraghi, Tofanelli e io, cominciammo a
radunare gli amici e a coinvolgerli nelle nostre stesse responsabilità.
Devo dire di più. Luraghi accarezzava da tempo il progetto di una Rivista
Aziendale e per questa iniziativa aveva ottenuto il consenso del dott. Alberto
Pirelli e l'adesione degli altri direttori. Credo che ne parlasse a Tofanelli
fin dall'estate del 1948. E a quel tempo, infatti, risalgono le prime "
avances " che Tofanelli mi rivolse per convincermi a tornare a Milano,
sulla breccia. E in verità, ripreso a Milano il mio lavoro accanto a Luraghi,
trovai dopo qualche giorno già pronti un progetto che " in nuce " o
in bozzolo, o in germe, conteneva l'idea della Rivista. Lo so che " dal
germe di un'idea può nascere Apollo oppure un mostro ": devo dire che per
il calco già pronto non fu difficile scegliere il materiale meglio rispondente,
meglio aderente al disegno di quella forma.
Fu discusso a lungo il titolo, fu vinta anche la nobile riservatezza del
dottor Piero e del dottor Alberto: ci si convinse tutti che quel nome, meglio
di qualsiasi sigla astratta e di qualunque proposito presuntuoso, poteva
accogliere in Italia e all'Estero una massa imponente di amici guadagnati in
settanta anni. Rimando il lettore alle precise parole introduttive che
comparvero nel primo numero, a pag. 8, con la firma di Alberto Pirelli.
Che cosa distinse subito, fin dai primi numeri,
Pubblicammo in quattro anni tutti articoli di prima mano, tutti scritti
inediti. Provocammo incontri tra scienziati e giornalisti, tra tecnici e poeti.
Senza tema di commettere eresie mandammo i reporters negli studi, nelle aule,
nei laboratori a sorprendere con lampi di magnesio personaggi tanto illustri
quanto riluttanti, come Severi. Amaldi, Marcello, De Marchi, Gabrielli, Nervi,
Colonnetti, Ponti, Fauser, Padre Gemelli, Smeraldi.
Se si pensa che soltanto in questi ultimi anni il giornalismo italiano ha
guadagnato " in funzione " quanto ha perduto " in
rappresentazione ", se si considera che è tanto difficile da noi torcere
il collo alla retorica e che si può essere tacciati di improntitudine se si chiede
uno scritto su tema obbligato, perché il bau bau dell'ispirazione, non è del
tutto sotterrato, si comprende meglio il significato di un lavoro che, bene o
male, era una prova di sottomissione, non certo di orgoglio.
All'intelligenza italiana non si sollecitarono sviolinate ed exploits, ma
piuttosto constatazioni, sopraluoghi, rendiconti. Tanto meglio se qualcuno
riusciva ad accendersi di fronte a una tesi, a un incontro imprevisto, a uno
spettacolo, a un dispositivo. Devo confessare sinceramente che il tempo dei
Francesco Redi e degli Algarotti, per non dire dei Galilei e dei Cattaneo è
davvero lontano. La nostra cultura è quasi tutta impastata di storia e di
oratoria. È impastata per fortuna anche di poesia. E io credo nell'acume, nella
curiorità, nell'entusiasmo dei poeti: credo nella loro capacità di
sorprendersi, di riflettere, di approfondire.
Vorrei dire, di straforo, che una delle mie ambizioni fu proprio questa:
provocare, stimolare una prosa analitica piuttosto che il solito pezzo
commemorativo, un referto e non un inno, un commento non una predica. Io sono
sicuro che se i nostri scienziati e i nostri tecnici considerassero l'esercizio
della scrittura alla stregua di un'operazione dignitosa, (una vera e propria
lima del pensiero) qual è sempre stata per Leonardo o per Cartesio, per Leon
Battista Alberti o per Maxwell, per Linneo o per Einstein, e se viceversa i
letterati e i filosofi e i critici, come hanno fatto del resto Goethe e Valery,
Hegel e Bergson, Giedion e Dewey, accogliessero, con rinnovata simpatia, le
ipotesi e i risultati del calcolo e dell'esperienza, una concordia nuova
potrebbe sorgere tra le inquietudini e le stanchezze del nostro tempo, non
voglio dire un nuovo mito. È molto probabile che questo genere di letteratura
" a comando ", questo giornalismo tecnico prenda il sopravvento sulle
pagine scritte in libertà, sulla prosa gratuita, sulla scrittura
disinteressata. Abbiamo letto in questi ultimi giorni una " memoria "
che accompagnava la relazione di un bilancio di una grande società finanziaria
belga: un saggio sull'utilizzazione delle materie prime che poteva portare una
firma celebre, ed era invece soltanto una plaquette anonima. Io aspetto il gran
giorno in cui il Regno dell'Utile sarà rinverdito dalla cultura, dalle
metafore, dall'intel1igenza. Quest'estate ho aperto qualche libro dei nostri
illuministi, l'abate Galiani, Filangieri, Verri. Mi veniva da confrontare la
nitidezza dei loro pensieri e delle loro parole alle sbavature, alla schiuma,
alla sciattezza di tanti articoli di fondo dei nostri giornaloni. Ho cercato
sempre di stimolare nei collaboratori la ricerca di un'espressione meditata: ma
c'è ancora molto cammino da percorrere per guadagnare precisione e leggerezza.
Ho rispolverato alcuni vecchi ricordi e qualche memoria di ieri. Ho voluto
pagare il mio tributo a una città adorabile, a degli amici carissimi. Per i
miei lettori di oggi, i lettori di " Civiltà delle macchine ", ho
creduto, necessario dopo quasi tre anni di sodalizio (" Civiltà delle
macchine " prese forma, appunto tra il settembre e l'ottobre del 1952)
mettere sul tavolo anche le mie carte più antiche. La nuova impresa, temeraria
e affascinante a cui mi sono votato, in questi ultimi tre anni ha successi
superiori a ogni speranza. Siamo sicuri di poter fare ancora meglio.
Friday, December 14, 2018
I limiti dello sviluppo
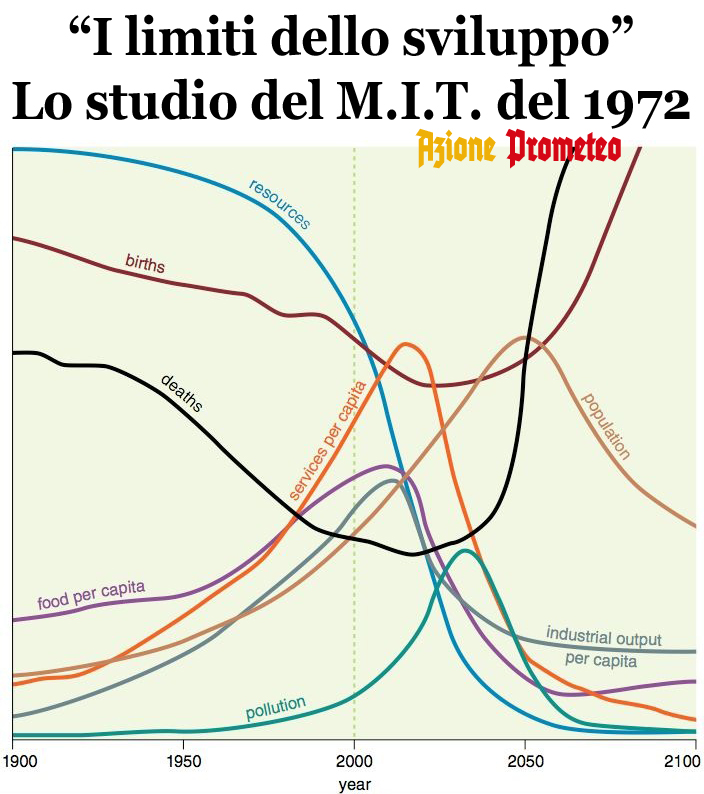


Il modello dinamico (Linguaggio DYNAMO)
A (t+delta t) = A (t) + (b-c) * delta t (modello discreto)
d A / dt = (b -c) (modello analitico)
Friday, December 13, 2019
Protesi
Protesi, ovvero la metamorfosi (1)
"La natura è in grado di compiere cose straordinarie senza l'intervento degli spiriti maligni. Se la natura, poi, è aiutata dal sapere e dall'ingegnosità umani, allora i risultati saranno quasi incredibili per gli inesperti" (Ruggero Bacone, I segreti dell'arte e della natura, cap. IV)Si racconta che un tempo, in un paese oggi scomparso e ormai ridotto a semplice landa desolata, arida e priva di ogni scrittura della passata storia, vivesse un popolo di uomini e donne supremamente intelligenti. Questi uomini e queste donne, bellissimi, non avevano bisogno di lavorare perché il loro pensiero era sufficiente a far sì che le risorse naturali bastassero non solo alle necessità, ma soprattutto al loro diletto. Conoscevano il piacere dei sei sensi e anche il procreare era ridotto a puro linguaggio, a trasmissione di emozioni e simpatia. Si è già detto che questi uomini e queste donne non avevano bisogno di lavorare. E perciò essi non avevano né mani né braccia.
Chi argomentasse, con il nostro modo di pensare, che essi erano più simili agli animali che a noi sbaglierebbe di grosso, perché in verità la loro prossimità agli dei era quanto noi non possiamo nemmeno immaginare.
Un giorno, una giovane di nome Protesi ebbe la ventura di essere trasportata dal mare, a causa di una tempesta, sulla spiaggia di un'isola abitata dagli uomini, ossia da esseri pari a quanti raccontano e tramandano questa storia. Quando, dopo un lungo sonno, Protesi si svegliò, trovò dinanzi a sé uomini e donne ben più brutti e rozzi di lei. In fondo anch'essi avevano una testa, un torso, un ombelico, due
gambe; sorridevano e muovevano le labbra; si toccavano e si facevano segni. Ma avevano qualcosa che li rendeva diversi: due articolazioni, simili alle gambe, ma più sottili, dotate di estremità ramificate e estremamente mobili si dipartivano dalle spalle, leggermente al di sopra e a fianco delle mammelle. Usavano questi rami per afferrare le pietre, per spezzare le foglie degli alberi, per staccare gli acini dai grappoli e per disporli in file ordinate, per tracciare insulsi segni sulla sabbia. Ciò che più impressionò Protesi fu il vedere un vecchio, ormai cieco, usare le mani (così le chiamavano) per tamburellare su alcune canne, producendo in questo modo suoni mai ascoltati, strani, ma desiderabili. E fu colta da invidia.
Pregò allora gli dei che la facessero ritornare a casa e la rendessero simile agli uomini che aveva incontrato sull'isola. La richiesta parve agli dei alquanto strana, alcuni di essi rimasero dubbiosi, altri la ritennero completamente stupida, ma poiché le preghiere di Protesi erano insistenti e continue, e poiché gli dei si lasciano commuovere dalle loro creature, finalmente si convinsero nell'esaudire le preghiere della bellissima giovane. Nella fucina dove si forgiano tutte le cose del mondo, con i metalli più preziosi vennero fatti preparare due arti lucenti e mobilissimi, ciascuno terminante con cinque ramificazioni prensili. Dopo che gli arti furono ultimati, gli dei rapirono Protesi, ed immersala in un torpore soavissimo le applicarono gli arti esattamente a somiglianza di quelli ammirati negli uomini e nelle donne dell'isola. Quando si fu risvegliata dal torpore, prima di essere ricondotta tra i suoi simili, Protesi fu istruita sull'uso degli arti. Ma le si impose, come pagamento del dono ricevuto, di non svelare l'origine di questo dono così singolare. Protesi promise solennemente, e fu rimandata presso i suoi simili. Gli dei l'abbandonarono al suo destino.
Credeva che sarebbe stata accolta come una dea, onnipotente per i nuovi doni ricevuti, ma rimase ben presto delusa. Additata come una mutazione mostruosa della natura più abbietta, fu relegata presso il bosco sacro alle ninfe, in modo che si potesse purificare, vergine, consacrandosi a quanto la Natura prodiga ci fornisce nella frescura delle selve. Sola rimase per lunghi mesi trovando unico diletto nelle canne, che ora riusciva a divellere dal terreno, a tagliare con cura, a riunire in fasci ordinati per altezza. In esse soffiava e traeva melodie dolcissime.
Attirato dal suono, un giovane di cui rimane ancor oggi sconosciuto il nome, la avvicinò e l'amò. Noi tutti siamo figli di Protesi.
(1) Costituisce l’incipit del saggio Protesi, ovvero la metamorfosi, in "Iride", anno IX, n.19, dicembre 1996, pp.703 sgg.
Sunday, November 19, 2017
Il mezzo è il messaggio

Marshall McLuhan è stato uno dei più importanti analisti delle comunicazione di massa, dall'avvento della stampa sino al mondo della televisione. Il suo saggio più importante è stato Understanding Media (1964) (tradotto in italiano nel 1967 con il titolo Gli strumenti del comunicare). Il suo primo saggio (1951) è The Mechanical Bride (La sposa meccanica)

« Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un'azienda privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera terrestre »
(Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare).
Monday, October 14, 2019
Il mito secondo Lévi-Strauss
cos'è un mito?
CLAÙDE LÉVI-STRAUSS: È tutto il contrario di una domanda
semplice, perché si può rispondere in parecchi modi. Se
lo chiede a un indiano americano ci saranno forti probabilità
che risponda: una storia dei tempi in cui gli uomini e `
gli animali non erano ancora distinti. Questa definizione
mi sembra molto profonda, perché, malgrado le nuvole
d'inchiostro sollevate dalla tradizione ebraico-cristiana p
mascherarla, nessuna situazione mi pare più tragica, più
offensiva per il cuore e per l'intelligenza, di quella
di un'umanità che coesiste con altre specie viventi su una terra
di cui queste ultime condividono l'usufrutto e con le
quali non può comunicare. Si comprende come i miti rifiutino
di considerare questo vizio della creazione come originale;
che essi vedano nel'la sua comparsa l'evento inaugurale
della condizione umana e della sua debolezza. Si potrebbe
anche cercare di definire il mito per via di opposizione
ad altre forme della tradizione orale: leggenda, racconto...
Ma queste distinzioni non sono mai nette. Forse
queste forme non hanno esattamente lo stesso ruolo nelle
culture, ma sono prodotte dallo stesso modo di pensare, e
l'analista non può impedirsi di considerarle insieme. In
che cosa consiste questo modo di pensare? L'ho detto, al
contrario del metodo cartesiano, in un rifiuto di scomporre
la difficoltà, nel non rassegnarsi mai a risposte parziali,
nell'aspirare a spiegazioni che circoscrivano la totalità dei
fenomeni. È proprio del mito, messo di fronte a un problema,
di pensarlo 'come l'omologo di altri problemi che si
pongono su altri piani: cosmologico, fisico, morale, giuridico,
sociale, eccetera. E di rendere conto di tutti insieme.
Questo spiega i giochi ad incastro che lei mette in evidenza.
Ciò che un mito dice in un linguaggio che sembra adatto a
una certa sfera si diffonde in tutte le sfere in cui potrebbe
porsi un problema dello stesso tipo formale.
Claude Lévi-Strauss e Didier Eribon, Da vicino e da lontano, Milano : Rizzoli, 1988, pp. 193-4
Wednesday, November 8, 2017
Il pensiero selvaggio e il bricolage
2) idem, pag. 240
3) idem, pag. 28
4) idem, pag. 29-30
5) idem, pag. 30-31
6) idem, pag. 31-34
Sunday, October 18, 2020
Protesi, ovvero la metamorfosi
Miti postindustriali di Vittorio Marchis
Protesi, ovvero la metamorfosi (1)
"La natura è in grado di compiere cose straordinarie senza l'intervento degli spiriti maligni. Se la natura, poi, è aiutata dal sapere e dall'ingegnosità umani, allora i risultati saranno quasi incredibili per gli inesperti" (Ruggero Bacone, I segreti dell'arte e della natura, cap. IV)Si racconta che un tempo, in un paese oggi scomparso e ormai ridotto a semplice landa desolata, arida e priva di ogni scrittura della passata storia, vivesse un popolo di uomini e donne supremamente intelligenti. Questi uomini e queste donne, bellissimi, non avevano bisogno di lavorare perché il loro pensiero era sufficiente a far sì che le risorse naturali bastassero non solo alle necessità, ma soprattutto al loro diletto. Conoscevano il piacere dei sei sensi e anche il procreare era ridotto a puro linguaggio, a trasmissione di emozioni e simpatia. Si è già detto che questi uomini e queste donne non avevano bisogno di lavorare. E perciò essi non avevano né mani né braccia.
Chi argomentasse, con il nostro modo di pensare, che essi erano più simili agli animali che a noi sbaglierebbe di grosso, perché in verità la loro prossimità agli dei era quanto noi non possiamo nemmeno immaginare.
Un giorno, una giovane di nome Protesi ebbe la ventura di essere trasportata dal mare, a causa di una tempesta, sulla spiaggia di un'isola abitata dagli uomini, ossia da esseri pari a quanti raccontano e tramandano questa storia. Quando, dopo un lungo sonno, Protesi si svegliò, trovò dinanzi a sé uomini e donne ben più brutti e rozzi di lei. In fondo anch'essi avevano una testa, un torso, un ombelico, due
gambe; sorridevano e muovevano le labbra; si toccavano e si facevano segni. Ma avevano qualcosa che li rendeva diversi: due articolazioni, simili alle gambe, ma più sottili, dotate di estremità ramificate e estremamente mobili si dipartivano dalle spalle, leggermente al di sopra e a fianco delle mammelle. Usavano questi rami per afferrare le pietre, per spezzare le foglie degli alberi, per staccare gli acini dai grappoli e per disporli in file ordinate, per tracciare insulsi segni sulla sabbia. Ciò che più impressionò Protesi fu il vedere un vecchio, ormai cieco, usare le mani (così le chiamavano) per tamburellare su alcune canne, producendo in questo modo suoni mai ascoltati, strani, ma desiderabili. E fu colta da invidia.
Pregò allora gli dei che la facessero ritornare a casa e la rendessero simile agli uomini che aveva incontrato sull'isola. La richiesta parve agli dei alquanto strana, alcuni di essi rimasero dubbiosi, altri la ritennero completamente stupida, ma poiché le preghiere di Protesi erano insistenti e continue, e poiché gli dei si lasciano commuovere dalle loro creature, finalmente si convinsero nell'esaudire le preghiere della bellissima giovane. Nella fucina dove si forgiano tutte le cose del mondo, con i metalli più preziosi vennero fatti preparare due arti lucenti e mobilissimi, ciascuno terminante con cinque ramificazioni prensili. Dopo che gli arti furono ultimati, gli dei rapirono Protesi, ed immersala in un torpore soavissimo le applicarono gli arti esattamente a somiglianza di quelli ammirati negli uomini e nelle donne dell'isola. Quando si fu risvegliata dal torpore, prima di essere ricondotta tra i suoi simili, Protesi fu istruita sull'uso degli arti. Ma le si impose, come pagamento del dono ricevuto, di non svelare l'origine di questo dono così singolare. Protesi promise solennemente, e fu rimandata presso i suoi simili. Gli dei l'abbandonarono al suo destino.
Credeva che sarebbe stata accolta come una dea, onnipotente per i nuovi doni ricevuti, ma rimase ben presto delusa. Additata come una mutazione mostruosa della natura più abbietta, fu relegata presso il bosco sacro alle ninfe, in modo che si potesse purificare, vergine, consacrandosi a quanto la Natura prodiga ci fornisce nella frescura delle selve. Sola rimase per lunghi mesi trovando unico diletto nelle canne, che ora riusciva a divellere dal terreno, a tagliare con cura, a riunire in fasci ordinati per altezza. In esse soffiava e traeva melodie dolcissime.
Attirato dal suono, un giovane di cui rimane ancor oggi sconosciuto il nome, la avvicinò e l'amò. Noi tutti siamo figli di Protesi.
(1) Costituisce l’incipit del saggio Protesi, ovvero la metamorfosi, in "Iride", anno IX, n.19, dicembre 1996, pp.703 sgg.
Thursday, October 4, 2012
History of the World in 100 Objects
The Book and the 100 Objects in Wikipedia
BBC & the British Museum: A History of the Worls (download mp3 and transcript)
An example: Episode 100: A portable solar energy panel lamp.
Episode 100 transcript
Testo in italiano
Monday, November 4, 2019
Metron, la misura

(il testo completo è disponibile sul portale della didattica)
Wednesday, November 30, 2016
La storia dei colori

INDICE
I. Senso e corpo dei colori
II. Il colore come figura e destino
III. Colori e forma
IV. Disegno, colore, pittura
V. il colore e il suo ordine
VI. I colori azioni e passioni
VII. il colore del colore
VIII. Colore e colore
Bibliografia
Si parla di: Leonardo e Goethe, di Klee e di Wittgenstein, di Kandinski e Malevic, di Melville e di Scriabin, di Newton ed Eulero, e di molti altri ancora.
Saturday, November 21, 2015
... sulla inevitabile digitalizzazione delle cose
Mi dicono che si sono già fatti esperimenti per trasmettere, via cavo, non informazioni, "ma cose"; cioè fasci di elettroni con relativo programma per ricostruire le loro aggregazioni; d'altra parte tutti questi mirabilia li abbiamo già visti ai tempi della nostra infanzia nelle illustrazioni coloratissime dei giornaletti, tipo il Cartoccino, oggi venerati, raccolti nei musei, ma forse ma, studiati come profezie Gli effetti strepitosi della vernice contro la gravità, da spalmarsi sotto le scarpe, in modo da eliminare macchine rd arai, chi li ha dimenticati? Ma quand'è che verranno messi in funzione?
Che cosa ha a che fare, tutto ciò, con le cose e le immagini? Ahimè, moltissimo. Infittì il processo di smaterializzazione, condotto dall'arte contemporanea e su cui esiste ormai una bibliografia critica cospicua, dopo l'arte concettuale che sembrava costituirne una punta estrema, è continuato al di sotto del revival figurativo e narrativo, ambiguamente librato fra simbolismo, espressionismo e fumetti, che riempie di nuovo le case di quadri da appendere in salotto. È passato in mano dei tecnici, ma si badi: tecnici pericolosi, sperimentatori di nuovi sistemi TV, che hanno portato ultimamente ai grandi panorami circolari animati da ologrammi, programmatori ad altissimo livello, che dopo aver incominciato ad eliminare le biblioteche per sostituirle con banche dati stanno ora saggiando le possibilità (ancora imprevedibili) connesse con la digitalizzazione delle immagini e delle strutture pluridimensionali; ragazzi che si sono abituati a giocare di fronte ad uno scherano, invece clic con giocattoli meccanici o di plastica. II prossimo passo sarà inevitabilmente una serie di macchine utensili invisibili che agiranno tramite forze di cui sarà negata del tutto all'uomo la percezione, e di cui vedremo solo gli effetti. Macchine che sostituiranno, anche nella mitologia collettiva, gli angioli. Molto presto, anche, scomparirà del tutto il rumore, appena si produrranno a basso costo gli apparecchi già usati per le grandi macchine e che lo annullano mediante interferenze di onde sonore. L'elettricità, dominando rotta da sola, ricavata dal sole o anche solo da un lieve barlume, diventerà di nuovo, come ai suoi inizi, pura magia.
Tuesday, November 3, 2015
Machina / Ingenium
Thursday, October 18, 2018
I paradigmi dell'impero delle cose

RIFIUTI / SCARTI
RISORSE
RIVOLUZIONI TECNOLOGICHE
SEGNO / SEGNI
TASSONOMIA / TASSONOMIE
UTOPIE / DISTOPIE

