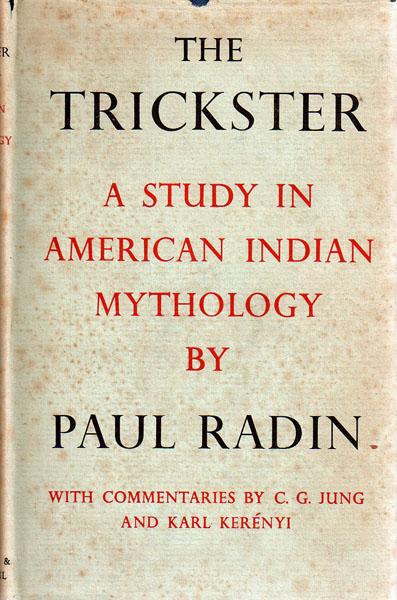"la Lettura", 2 dicembre 2018
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Showing posts with label anthropology. Show all posts
Showing posts with label anthropology. Show all posts
Saturday, December 8, 2018
Friday, October 26, 2018
Wednesday, October 10, 2018
Narrare
Se lo scienziato costruisce modelli della realtà, se l'ingegnere progetta, lo storico racconta.
Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal, 2013
L'istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani. Torino Bollati Boringhieri 2018
(un articolo di Mario Berenghi su "DoppioZero")
(un articolo di Mario Berenghi su "DoppioZero")

Jonathan Gottschall: We Are Storytelling Animals - DigitasLBi NewFront 2017
"L'animale narratore era l'uomo, l'unica creatura sulla terra che si raccontava storie per capire qualcosa su se stesso. Le storie erano sue per diritto di nascita. e nessuno poteva torgliergliele." (Salman Rushdie, Joseph Anton. Memoria, Milano : Mondadori, 2012, p.25)
"L'animale narratore era l'uomo, l'unica creatura sulla terra che si raccontava storie per capire qualcosa su se stesso. Le storie erano sue per diritto di nascita. e nessuno poteva torgliergliele." (Salman Rushdie, Joseph Anton. Memoria, Milano : Mondadori, 2012, p.25)
Tuesday, December 12, 2017
Un esercizio di tassonomia antropologica
Le "cose" portate dagli studenti
Le "categorie" tassonomiche
Tabella di lavoro contenente le tre "classi" tassonomiche
(NOTA: la Tabella di lavoro in Excel è scaricabile sul portale della didattica)
Monday, December 11, 2017
Il kitsch
Il kitsch rappresenta ogni degenerazione dell'arte in senso volgare e dozzinale. Un video di "Wired" che spiega il kitsch. Ecco un articolo di Marco Belpoliti
Thursday, December 7, 2017
André Leroi-Gourhan
André Leroi-Gourhan (Parigi, 25 agosto 1911 – Parigi, 19 febbraio 1986) etnologo, archeologo e antropologo ha scritto il trattato Il gesto e la parola (Torino : Einaudi, 1977).

Gli oggetti esemplari (2)
Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia, a cura di Pier Giorgio Solinas, Montepulciano : Editori del Grifo, 1989.
Da: Maria Luisa Meoni, La zappa, il gesto, la norma. Per una sintassi del processo tecnico e delle particolarità culturali.
Gli oggetti esemplari
Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia, a cura di Pier Giorgio Solinas, Montepulciano : Editori del Grifo, 1989.
Da: Classi astratte e cose concrete, di Alberto Mario Cirese
Da: Classi astratte e cose concrete, di Alberto Mario Cirese
Classificazioni formali
Tavola delle percussioni di Leroi-Gourhan
Monday, November 13, 2017
Bruce Chatwin
"A parte uno
scrittoio da viaggio del barone Vivant Denon e una chaise de camp d'acciaio, il
mobilio della stanza era di poco conto. Mr Tod diceva di detestare ogni mobile
che non stesse sul basto di un mulo. C'erano tuttavia due poltrone a origlieri
con fodere di lino senza fronzoli. E su tre tavoli a tempera grigia era
disposta la collezione di oggetti rari che Mr Tod, per un processo di
eliminazione e per le esigenze di viaggio, aveva ridotto allo scarno
essenziale.
In nessuna
delle opere d'arte si scorgeva l'immagine umana.
Gli
inventari sono una lettura tediosa; mi limiterò quindi a elencare un fang-i
Shang di bronzo con la patina « a buccia di melone » ; uno specchio magico di
Norimberga; un piatto azteco con un fiore purpureo; il reliquiario di cristallo
di uno stupa del Gandhara; un bezoàr montato in oro; un flauto di giada; una
cintura di wampum; un falco Horus della prima dinastia, di granito rosa; e
certi monili eschimesi, in avorio di tricheco, con figure di animali che per
quanto stilizzati sembravano respirare. Devo tuttavia segnalare tre arnesi da
taglio, poiché erano il tema di un saggio di Maximilian Todd, Die Àsthetik der Messerschàrfe,
pubblicato a Jena nel 1941, in cui egli sosteneva che tutte le armi sono
artigli o canini artificiali, e danno a chi le usa il piacere noto ai carnivori
quando sbranano la carne viva.
Questi
arnesi erano:
1. Un'azza
acheuleana di selce proveniente dalle ghiaie della Senna, con l'attrattiva
supplementare di una montatura Louis Quinze in bronzo dorato e la dedica « Pour
le Roi ».
2. Un
pugnale germanico dell'Età del Bronzo, trovato dal padre di Mr Tod nello scavo
di un tumulo a Ùckermùnde, sul Baltico.
3. Una lama
di spada proveniente dalla collezione del suo amico e maestro Ernst Grùnwald,
datata 1279 e firmata da Toshiru Yoshimitsu, il più grande spadaio del Giappone
medievale. (Un segno sulla lama indicava che la spada aveva eseguito
felicemente, su un criminale, il movimento detto tai, un colpo dal basso in
alto che tronca di netto il corpo dall'anca destra alla spalla sinistra).
Né ometterò
una descrizione di tre altri pezzi della stessa collezione Grùnwald: una tazza
da tè di Kóetsu intitolata Montagne in inverno; una scatola di scorza di
betulla intrecciata della Tribù d'Oro della Manciuria; e un blocco di pietra
blu-nera con segni verdi e l'iscrizione: « Questa pietra d'inchiostro con Occhi
Morti proviene dal Vecchio Pozzo della Rupe Inferiore di Tuan Hsi e appartenne
al pittore Mi Fei ».
Nella
scatola di scorza Mr Tod custodiva i suoi due beni più cari: una calligrafia
del maestro zen Sen Sotan, con la massima: « L'uomo in origine non possiede
nulla »; e un rotolo di paesaggio dello stesso Mi Fei - pittore di montagne
simili a nuvole e di nuvole simi i a montagne, ubriacone, petromane,
intenditore di pietre d'inchiostro, odiatore degli animali domestici, che
errava per i monti portando sempre con sé la sua inestimabile collezione
d'arte.
Le pareti
della stanza erano nude; c'era soltanto, in cornice, una calligrafia turca su
foglia d'oro, con un verso di Rumi (Mathnawi, VI, 723): «Essere un morto che
cammina, uno che è morto prima di morire ».
La
biblioteca di Mr Tod - almeno, la sua parte visibile - non era una biblioteca
nel senso corrente ma una raccolta di testi che avevano per lui un significato
speciale. Erano legati in carta grigia e custoditi in una cassetta da viaggio
di zigrino. Li elencherò nell'ordine in cui erano disposti, perché quest'ordine
dà di per sé una certa idea della personalità del proprietario: il trattato di
Cassiano sull'accidia; il poema irlandese antico La capanna dell'eremita; il
saggio poetico di Hsien Yin Lung Sul
vivere nelle montagne; un facsimile del De
arte venandi cum avibus dell'imperatore Federico II; lo scritto di Abu'l
Fazl su Akbar e i suoi piccioni
viaggiatori; le Notes on the Colour of
Water and Ice di John Tyndall; L'ironia
delle cose di Hugo von Hofmannsthal; Landor's Cottage di Poe; il
Pellegrinaggio di Caino di Wolfgang Hammerli; il poemetto in prosa di
Baudelaire con il titolo inglese Anywhere
out of this World! ; e l'edizione 1840 dell’Étude
sur les glaciers di Louis Agassiz, con l'appendice di cromolitografie della
Jungfrau e di altri ghiacciai svizzeri.
Dovrebbe
essere chiaro, anche per il lettore più sbadato, che Maximilian Tod sono io. La
mia storia è priva di importanza. Detesto le confidenze. D'altronde, sono
convinto che un uomo è la somma delle sue cose, anche se alcuni fortunati sono
la somma di un'assenza di cose. Qualche dato biografico può tuttavia giovare a
mettere le mie acquisizioni in una sequenza cronologica."
(da: Il patrimonio di Maximilian Tod, in
Bruce Chatwin, Anatomia dell’irrequietezza,
Milano : Adelphi, 1996, pp. 80-82)
Sunday, November 12, 2017
Saturday, November 11, 2017
Mitologie contemporanee
Nel 1957 Roland Barthes scrive Mythologies (Paris : du Seuil) che viene tradotto in italia con il titolo Miti d'oggi (Torino : Einaudi, 1974). La prima edizione italiana appare dall'Editore Lerici nel 1962.
La cultura
Edward Tylor (1832-1917), uno dei padri dell’antropologia culturale, in un’opera del 1871, Primitive Culture, afferma che: “la cultura è quell’insieme complesso che comprende il sapere, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume, e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società”.
L'uomo è un animale imperfetto che attraverso la cultura si adatta alle condizioni ambientali e sopravvive.
Pico della Mirandola: L'uomo è interprete del suo destino.
L'uomo è un animale imperfetto che attraverso la cultura si adatta alle condizioni ambientali e sopravvive.
Pico della Mirandola: L'uomo è interprete del suo destino.
Wednesday, November 8, 2017
Il pensiero selvaggio e il bricolage
Il “pensiero selvaggio che non è, per noi, il pensiero dei
selvaggi, né quello di un’umanità primitiva o arcaica, bensì il pensiero allo
stato selvaggio, distinto dal pensiero educato o coltivato proprio in vista di
un rendimento”. (Claude Levi-Strauss, Il pensiero selvaggio [1])
”esistono ancora alcune zone in cui il pensiero selvaggio
si trova, come le specie selvatiche, relativamente protetto: è il caso
dell’arte, cui la nostra civiltà accorda lo statuto di parco nazionale con
tutti i vantaggi e gli inconvenienti che comporta una formula tanto
artificiale; e soprattutto è il caso di tanti settori della vita sociale ancora
incolti ove, per indifferenza o per impotenza, e senza che il più delle volte
sappiamo il perché, il pensiero selvaggio continua a prosperare. (2)
“La poesia del bricolage nasce anche e soprattutto dal
fatto che questo non si limita a portare a termine, o ad eseguire, ma «parla»,
non soltanto con le cose, […], ma anche mediante le cose: raccontando
attraverso le scelte che opera tra un numero limitato di possibili, il
carattere e la vita del suo autore. Pur senza mai riuscire ad adeguare il suo
progetto, il bricoleur vi mette sempre qualcosa di sè.”
Claude Levi-Strauss parla de “l’esistenza di due diverse
forme di pensiero scientifico, funzioni certamente non di due fasi diseguali
dello sviluppo dello spirito umano, ma dei due livelli strategici in cui la
natura si lascia aggredire dalla conoscenza scientifica: l’uno
approssimativamente adeguato a quello della percezione e dell’intuizione,
l’altro spostato di piano; come se i rapporti necessari che costituiscono
l’oggetto di ogni scienza, neolitica o moderna che sia, fossero raggiungibili
attraverso due diverse strade, l’una prossima alla intuizione sensibile,
l’altra più discosta.” (3)
“Proprio per sua essenza, questa scienza del concreto
doveva limitarsi a risultati diversi da quelli destinati alle scienze esatte e
naturali, ma non per questo essa fu meno scientifica e i suoi risultati meno
reali: questi ultimi anzi, impostisi diecimila anni prima degli altri,
rimangono ancora e sempre il sostrato della nostra civiltà. D’altronde,
sopravvive fra noi una forma di attività che, sul piano tecnico, ci consente di
renderci conto abbastanza bene delle caratteristiche, sul piano speculativo, di
una scienza che preferiamo chiamare ’primaria’ anziché primitiva: questa forma
è di solito designata col termine bricolage. […] Oggi per bricoleur s’intende
chi esegue un lavoro con le proprie mani, utilizzando mezzi diversi rispetto a
quelli usati dall’uomo di mestiere. Ora, la peculiarità del pensiero mitico sta
proprio nell’esprimersi attraverso un repertorio dalla composizione eteroclita
che, per quanto esteso, resta tuttavia limitato: eppure di questo repertorio
non può fare a meno di servirsi, perché non ha niente altro tra le mani. Il
pensiero mitico appare così come una sorta di bricolage intellettuale, il che
spiega le relazioni che si riscontrano tra i due. Come il bricolage sul piano
tecnico, la riflessione mitica può ottenere sul piano intellettuale risultati
veramente pregevoli e imprevedibili;” (4)
“Vale la pena di approfondire ulteriormente questo
paragone, perché ci facilita l’accesso ai rapporti reali esistenti fra i due
tipi di conoscenza scientifica che abbiamo ora distinti. Il bricoleur è capace
di eseguire un gran numero di compiti differenziati, ma, diversamente dall’ingegnere,
egli non li subordina al possesso di materie prime e di arnesi, concepiti e
procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto: il suo universo
strumentale è chiuso, e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi
sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè a un insieme via via ‘finito’
di arnesi e di materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di
questo insieme non è in rapporto col progetto del momento, né d’altronde con
nessun progetto particolare, ma è il risultato contingente di tutte le
occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di
conservarlo con i residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti.
L’insieme dei mezzi del bricoleur non è quindi definibile in base a un progetto
(la qual cosa presupporrebbe, almeno in teoria, l’esistenza di tanti complessi
strumentali quanti sono i generi di progetto, come accade all’ingegnere); esso
si definisce solamente in base alla sua strumentalità, cioè, detto in altre
parole e adoperando lo stesso linguaggio del bricoleur, perché gli elementi
sono raccolti o conservati in virtù del principio che ‘ possono sempre servire
’. Simili elementi sono dunque specificati solo a metà: abbastanza perché il
bricoleur non abbia bisogno dell’assortimento di mezzi e di conoscenze di tutte
le categorie professionali, ma non tanto perché ciascun elemento sia vincolato
ad un impiego esattamente determinato. Ogni elemento rappresenta un insieme di
relazioni al tempo stesso concrete e virtuali: è un operatore, ma utilizzabile
per una qualsiasi operazione in seno a un tipo. (5)
“Osserviamolo all’opera (ci si riferisce al bricoleur ndr):
per quanto infervorato dal suo progetto, il suo modo pratico di procedere è
inizialmente retrospettivo: egli deve rivolgersi verso un insieme già costituito
di utensili e di materiali, farne e rifarne l’inventario, e infine,
soprattutto, impegnare con essa una sorta di dialogo per inventariare, prima di
sceglierne una, tutte le risposte che l’insieme può offrire al problema che gli
viene posto. Egli interroga tutti quegli oggetti eterocliti che costituiscono
il suo tesoro, per comprendere ciò che ognuno di essi potrebbe ‘significare’,
contribuendo così alla definizione di un insieme da realizzare che alla fine,
però, non differirà dall’insieme strumentale se non per la disposizione interna
delle parti. Quel blocco cubico di quercia potrebbe servire da bietta per
rimediare all’insufficienza di un asse di abete, oppure da piedistallo, cosa
che permetterebbe di valorizzare la venatura e la levigatezza del vecchio
legno. In un caso sarà estensione, nell’altro materia. Ma queste possibilità
vengono sempre limitate dalla storia particolare di ciascun pezzo e da quanto
sussiste in esso di determinato, dovuto all’uso originale per cui era stato
preparato o agli adattamenti subiti in previsioni di altri usi. Come le unità
costruttive del mito, le cui possibilità di combinazione sono limitate dal
fatto di essere ricavate da una lingua dove possiedono di già un senso che ne
riduce la libertà di impiego, gli elementi che il bricoleur raccoglie e
utilizza sono ‘previncolati’. D’altra parte la decisione dipenderà dalla
possibilità di permutare un altro elemento nella funzione vacante, così che
ogni scelta trarrà seco una riorganizzazione completa della struttura che non sarà
mai identica a quella vagamente immaginata né ad altra che avrebbe potuto
esserle preferita. In certo qual modo anche l’ingegnere interroga, poiché anche
per lui esiste un ‘interlocutore’ , determinato dal fatto che i mezzi, le
capacità e le conoscenze in suo possesso non sono mai illimitati , e che, in
questa forma negativa, egli urta contro una resistenza con la quale gli è
indispensabile venire a patti. Si potrebbe essere tentati di dire che
l’ingegnere interroga l’universo, mentre il bricoleur si rivolge a una raccolta
di residui di opere umane , cioè a un insieme culturale di sottordine. […] la
caratteristica del pensiero mitico, come del bricolage sul piano pratico, è di
elaborare insiemi strutturati, non direttamente per mezzo di altri insiemi strutturati,
ma utilizzando residui e frammenti di eventi […] il pensiero mitico, da vero
bricoleur, elabora strutture combinando insieme eventi, o piuttosto residui di
eventi, mentre la scienza, che ‘cammina’ in quanto si instaura, crea, sotto
forma di eventi, i suoi strumenti e i suoi risultati, grazie alle strutture che
fabbrica senza posa e che sono le sue ipotesi e le sue teorie. Ma non
equivochiamo: non si tratta di due stadi o di due fasi dell’evoluzione del
sapere, poiché i due modi di procedere sono ugualmente validi.”(6)
2) idem, pag. 240
3) idem, pag. 28
4) idem, pag. 29-30
5) idem, pag. 30-31
6) idem, pag. 31-34
Sunday, October 22, 2017
Wednesday, December 14, 2016
L'antropologia culturale
L'antropologia di Lévi-Strauss (una lezione di Gianni Vattimo)
La diversità culturale, una lezione di Marco Aime
Monday, December 12, 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)